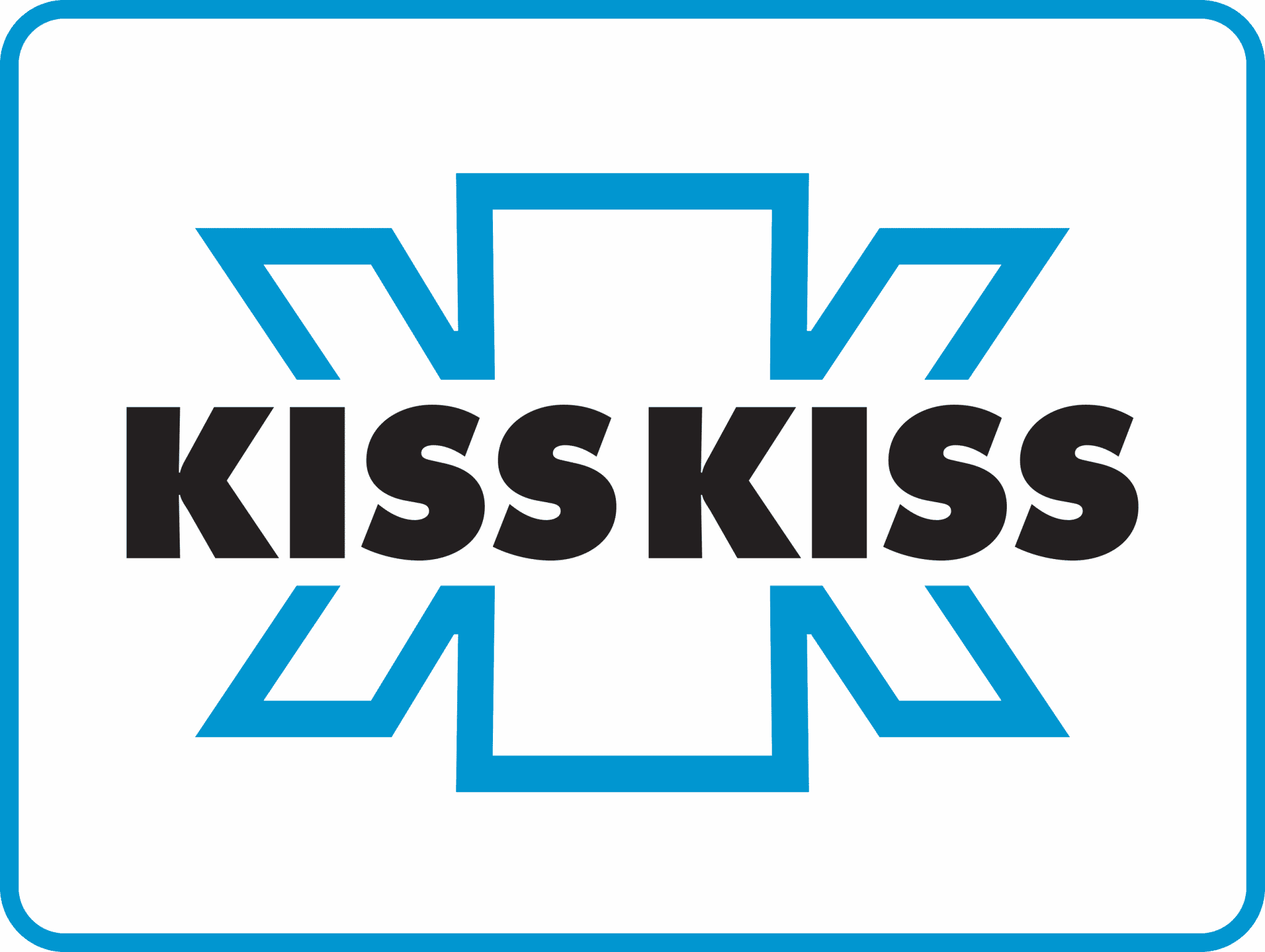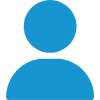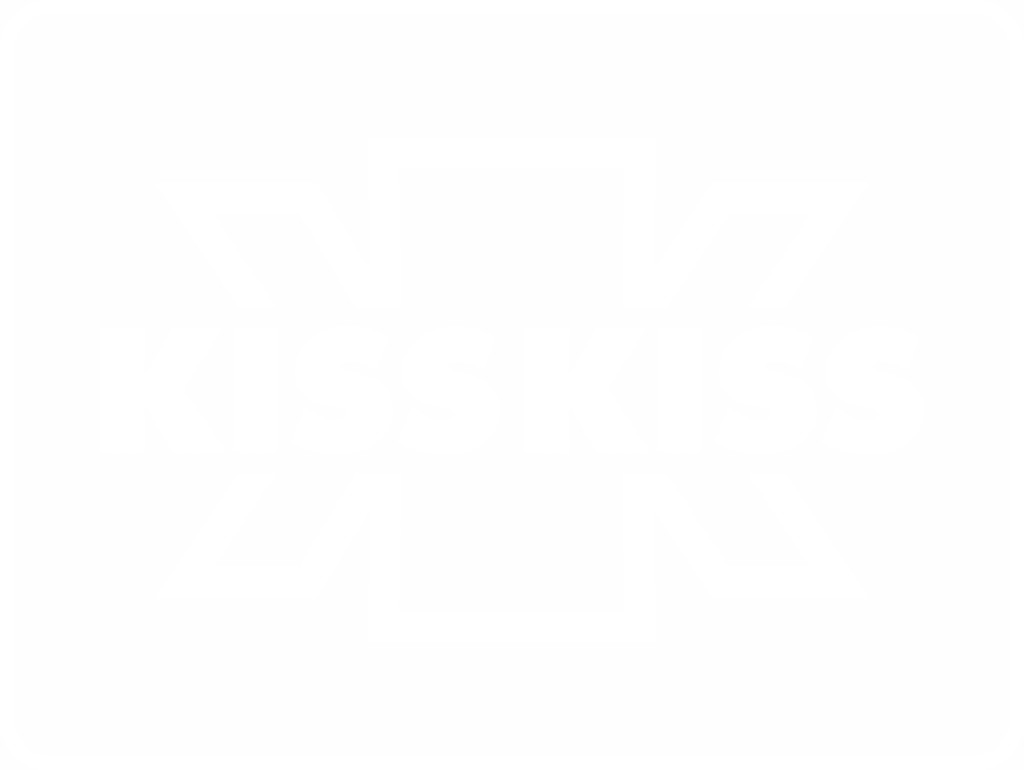Elvira Notari nasce a Salerno nel 1875. È una delle prime donne (se non la prima, stando a molti storici) a dirigere film in Italia quando il cinema era ancora ai suoi albori. Con suo marito, Nicola Notari, fondò la “Dora Film”, una casa di produzione che realizzò decine di cortometraggi, numerosi film e molti documentari.
Quello che la distingueva era un approccio fortemente realistico: ha spesso recato su schermo storie di poveri, umili, persone comuni; ha fatto uso di attori non professionisti; ha trattato temi di marginalità e violenza, denunciando le disuguaglianze. Del suo lavoro rimane purtroppo poco, perché molte pellicole sono andate perdute. La censura del regime fascista, le condizioni precarie della conservazione delle pellicole, e il semplice degrado hanno contribuito a questo oblio.
Il documentario e il “ripescaggio” culturale
Elvira Notari. Oltre il silenzio è il titolo del nuovo documentario che ha messo in luce la sua storia, iniziata dall’adolescenza, proseguita con la produzione di decine di materiali filmici, fino al progressivo oscuramento della sua figura nella storiografia ufficiale.
Il progetto è parte del cosiddetto “anno notariano”, iniziativa promossa dal governo italiano con l’intento di recuperare, valorizzare e divulgare l’opera e l’influenza della regista. Il documentario è emblematico non solo per riscoprire lavori perduti, ma anche per interrogarsi su che cosa significhi fare cinema “dal basso”, fuori dagli schemi ufficiali, con poche risorse ma grande coraggio artistico.
Perché la sua storia conta oggi
In un’epoca in cui il panorama cinematografico era dominato da figure maschili, Elvira Notari emerge come un caso unico: una donna che dirige, produce, distribuisce e che ha una visione autonoma. Riscoprire la sua figura significa anche recuperare una memoria perduta di indipendenza artistica femminile. Elvira Notari si distingue come una pioniera di un cinema realistico e sociale che, molto prima dell’avvento del neorealismo italiano, ha saputo raccontare tematiche profonde come la povertà, l’emarginazione, l’uso del dialetto e la vita di strada. Questi elementi, centrali nel suo lavoro, anticipano sensibilità e sguardi che solo decenni dopo saranno riconosciuti come fondamentali per la storia del cinema italiano. Tuttavia, gran parte del suo prezioso lavoro è andato perduto, rappresentando non solo una perdita personale e familiare, ma un vuoto culturale significativo: ogni film o documento scomparso è un tassello mancante nel mosaico della memoria collettiva del cinema nazionale. Questa situazione mette in luce la fragilità del patrimonio audiovisivo e l’importanza di curarne l’archiviazione e la tutela. La riscoperta di Notari, resa possibile grazie all’impegno congiunto di registi, storici, festival, istituzioni culturali, archivisti e un pubblico sempre più interessato, testimonia come la salvaguardia della memoria artistica sia un’operazione collettiva. Il documentario che le è dedicato rappresenta un potente strumento per riportare la sua figura al centro del dibattito pubblico, trasmettendo conoscenza e stimolando una nuova curiosità nei confronti di un patrimonio finora poco valorizzato.
Le reazioni e il dibattito
Il lavoro di Ciriaci ha suscitato attenzione critica e curiosità: molti giornalisti e studiosi hanno elogiato il valore del documentario come operazione di memoria e giustizia storica. È anche venuta fuori la domanda: quanti altri autori, autrici, cortometraggi, film popolari e innovativi sono caduti nell’oblio per ragioni non legate al valore artistico, ma al contesto storico, politico, economico?
Al pubblico, la riscoperta è piaciuta: nelle sale dove il film è stato proiettato, sono comparsi spettatori appassionati, giovani studiosi, cinefili, curiosi spinti dalla voglia di conoscere “quel cinema che non c’è più”. Le recensioni parlano di un lavoro toccante, ben documentato, che fa vedere non solo i frammenti cinematografici, ma la vita dietro la macchina da presa.
Un racconto che continua
La riscoperta di Elvira Notari non è la fine di nulla, ma l’inizio di un discorso più ampio: che cosa perdiamo quando dimentichiamo chi ha fatto cinema con coraggio? Come cambierebbe la percezione del cinema italiano se includessimo pienamente voci che per decenni sono state “fuori dal canone”? Come si intrecciano le storie personali, le condizioni sociali e la produzione di cultura?
Chi ama il cinema oggi può sentirsi coinvolto non solo come spettatore, ma anche come custode: scegliere film, documentari, partecipare a proiezioni, sostenere archivi, leggere e parlare. È una responsabilità culturale che ognuno può sentire, perché il valore di Elvira Notari sta nel fatto che non era un caso isolato, ma parte di una corrente dimenticata.