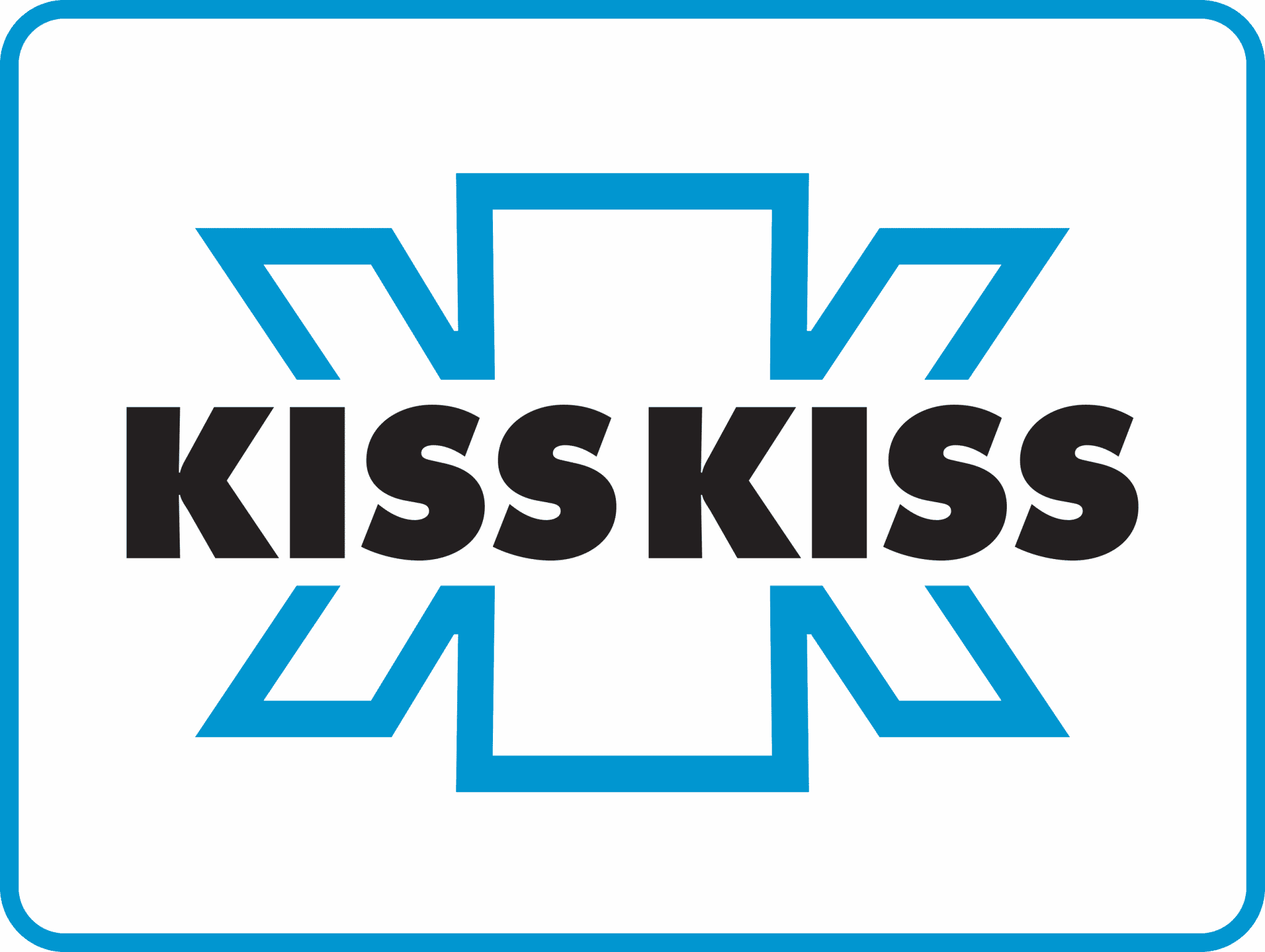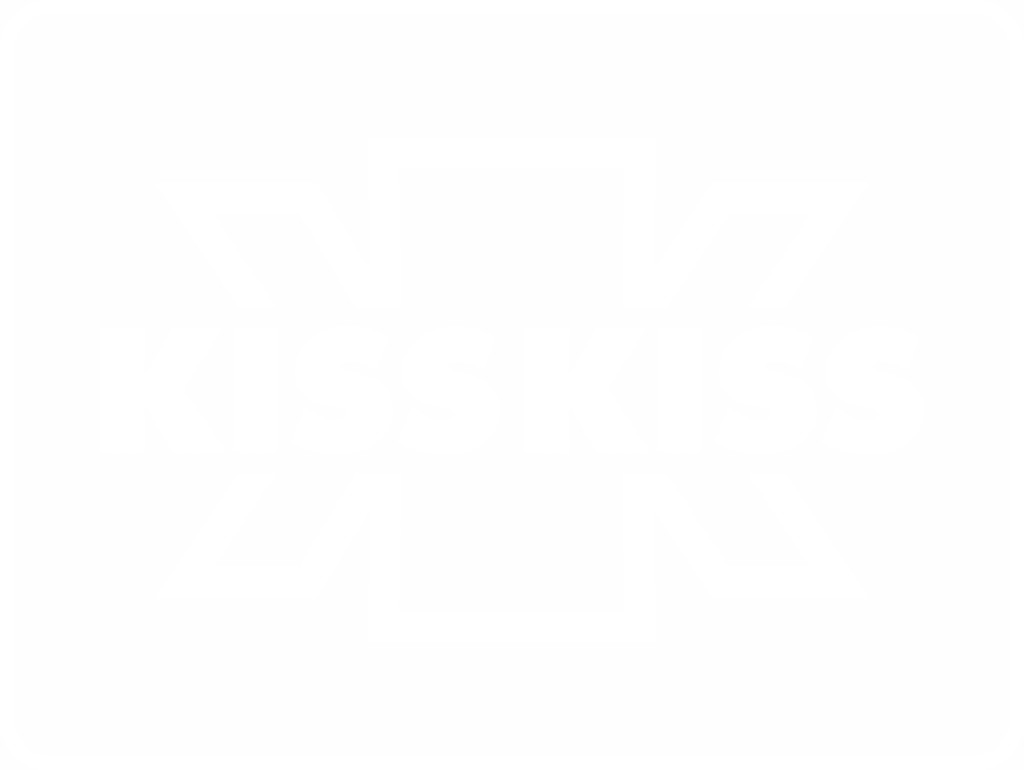Il 25 aprile, giorno della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, risuona puntualmente in ogni piazza italiana un canto diventato simbolo della libertà: Bella Ciao. Ma nonostante la sua fama planetaria e il legame ormai indissolubile con la Resistenza italiana, la storia di questo inno è molto più complessa – e in parte sorprendente – di quanto si possa pensare. Contrariamente all’opinione diffusa, Bella Ciao non nacque durante la Resistenza, né fu cantata dai partigiani sui monti nel 1943-1945. La sua storia affonda invece le radici nella tradizione popolare, per poi emergere come canzone di protesta solo molti anni dopo la fine della guerra.
Origini popolari: dalle mondine ai canti di lotta
Per comprendere le origini di Bella Ciao, bisogna tornare indietro nel tempo, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, quando le mondine – le giovani lavoratrici stagionali delle risaie della pianura padana – intonavano canti di protesta contro le durissime condizioni di lavoro. In particolare, un brano conosciuto come Alla mattina appena alzata presenta una struttura melodica e testuale che richiama da vicino quella di Bella Ciao. Si trattava di un canto di denuncia contro lo sfruttamento, cantato da donne che, immerse fino alle ginocchia nell’acqua delle risaie, combattevano ogni giorno per i propri diritti. Questa “Bella Ciao delle mondine” era molto diversa dal testo che oggi conosciamo. Parlava di sveglie all’alba, padroni oppressivi e di dignità sul lavoro. La melodia – molto simile a quella attuale – veniva tramandata oralmente, senza spartiti ufficiali, come accadeva nella tradizione popolare.
L’adattamento partigiano: una nuova versione, una nuova lotta
La versione che oggi conosciamo come Bella Ciao, quella del partigiano che si alza al mattino e che chiede di essere sepolto in montagna sotto l’ombra di un bel fior, non risale alla Seconda Guerra Mondiale. Non ci sono testimonianze scritte o registrazioni che attestino l’uso di Bella Ciao da parte dei partigiani tra il 1943 e il 1945. Il canto non compare nei canzonieri partigiani originali né fu menzionato in modo sistematico dai reduci della Resistenza nell’immediato dopoguerra. Fu solo negli anni ’50 e ’60 che il brano iniziò a diffondersi con il testo partigiano che conosciamo oggi. Alcuni storici e musicologi ipotizzano che la rielaborazione sia avvenuta in ambito culturale e politico legato alla sinistra, nei circoli del Partito Comunista Italiano e nei festival dell’Unità. Bella Ciao venne proposta come canto simbolico della Resistenza durante gli incontri antifascisti e i raduni della sinistra giovanile. In questo contesto venne adattata, adottata e infine consacrata. La prima grande diffusione ufficiale avvenne nel 1964 durante il Festival mondiale della gioventù socialista a Berlino Est, dove delegazioni italiane la cantarono come simbolo della Resistenza. Da lì partì la sua vera fortuna internazionale.
Il successo planetario: da icona antifascista a simbolo globale
Negli anni ’70 Bella Ciao si diffuse oltre i confini italiani, diventando un inno internazionale contro l’oppressione e le dittature. Venne cantata in manifestazioni, cortei, rivoluzioni. Dal Portogallo della Rivoluzione dei Garofani (1974) fino alle proteste in America Latina, passando per i movimenti operai francesi e tedeschi. Il brano fu reinterpretato in decine di lingue, registrato da artisti folk e rock, dai cori di piazza e dalle scuole. La sua potenza comunicativa – con parole semplici, dirette, toccanti – la rese universale: la storia del partigiano che affronta la morte in nome della libertà diventò la storia di ogni oppresso, in qualunque parte del mondo.
L’inaspettata rinascita: “La Casa di Carta” e la generazione streaming
Negli anni Duemila, dopo un periodo di relativo silenzio, Bella Ciao è tornata clamorosamente alla ribalta grazie alla celebre serie televisiva spagnola La Casa di Carta (2017), dove è utilizzata come colonna sonora simbolica della ribellione dei protagonisti contro il potere costituito. La versione cantata da El Profesor e Berlino ha fatto il giro del mondo, scalando le classifiche su Spotify e YouTube, con centinaia di milioni di ascolti. Molti giovani – ignari della sua origine partigiana – hanno scoperto la canzone proprio attraverso la serie Netflix, aprendosi poi alla sua storia e al suo significato più profondo. Da allora Bella Ciao è stata cantata nelle piazze dell’Iran durante le proteste del 2022, in quelle della Turchia, della Birmania, fino alla recente primavera femminista in Argentina.
Una canzone “nata dopo”, ma sempre attuale
Paradossalmente, dunque, Bella Ciao non è nata con la Resistenza, ma è diventata la sua voce più celebre. È un inno costruito a posteriori, ma tanto potente da essere adottato da chi davvero la Resistenza l’ha vissuta, e ancor più da chi, nel mondo, continua a lottare per libertà, diritti e democrazia. Il suo successo è figlio di un’ambiguità storica, ma anche di una straordinaria forza evocativa. Oggi più che mai, mentre i valori della Resistenza rischiano di essere dimenticati o riscritti, Bella Ciao ricorda a ogni generazione che la libertà va difesa, anche a costo della vita. E così, ogni 25 aprile, quando risuona nelle piazze, non è solo un rito. È un atto di memoria, un canto di speranza, una promessa collettiva: “E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.”