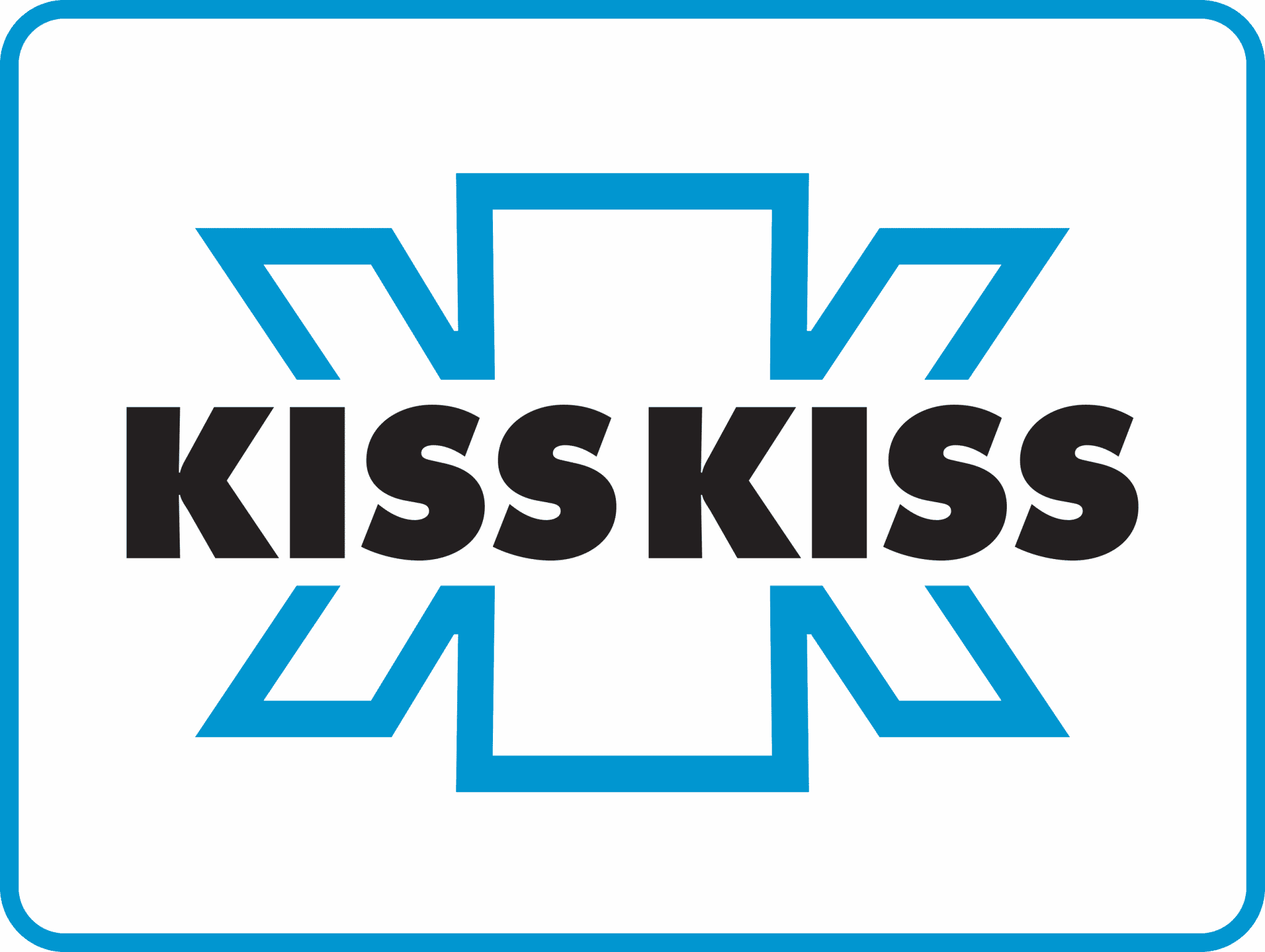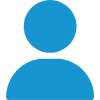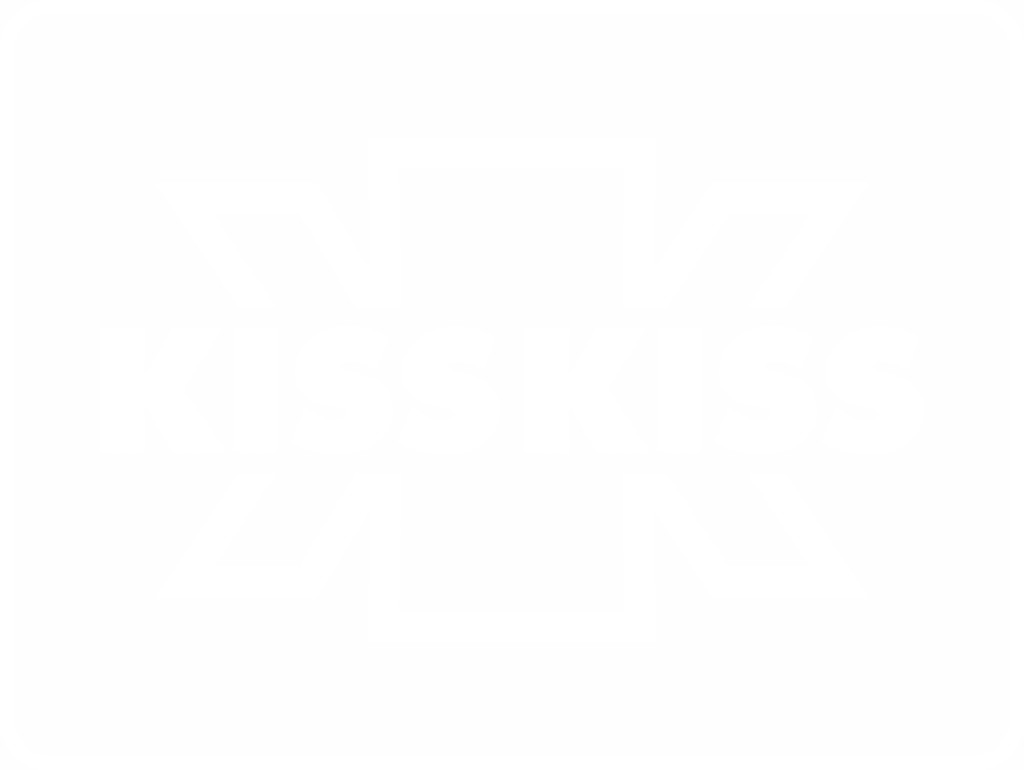Era il 4 ottobre del 1983 quando Pozzuoli e zone limitrofe furono svegliate da una violentissima scossa di terremoto -settimo grado della scala Mercalli- la più forte di una intensa attività tellurica, che in alcuni casi faceva registrare anche cinquecento scosse al giorno, sintomo di una crisi bradisismica (un periodico sollevamento e abbassamento del terreno tipico di questa zona). A distanza di quarant’anni, la terra ha ripreso a tremare e il fenomeno torna ad interessare i Campi Flegrei, tra la periferia ovest di Napoli e la Solfatara. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata anche questa mattina, alle 10.46, l’ultima di uno sciame sismico iniziato il 7 settembre.
Con l’aumentare della paura dei cittadini, cresce anche la preoccupazione degli esperti e della politica. “L’attenzione su quanto sta accadendo è massima. Dobbiamo guardarci da previsioni scientificamente non supportate che travalicano i limiti di quanto possiamo dire al momento sull’evoluzione della situazione” spiega Andrea Billi, geologo dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr. “Il rischio zero non esiste” ribadisce il ministro per la protezione civile Musumeci assicurando però che il governo sta preparando un decreto-legge sui Campi Flegrei che entro pochi giorni sarà all’esame del consiglio dei ministri. “Nel provvedimento -prosegue Musumeci- è previsto un Piano di esodo in relazione al bradisismo, perché per il rischio vulcanico il piano esiste già e va solo aggiornato”. Si tratta di uno strumento che, come ha spiegato anche il ministro, verrà adottato unicamente in casi di estrema necessità e che prevede assistenza alla popolazione ed eventuali forme di allontanamento temporaneo per i territori particolarmente colpiti dal fenomeno.
Il piano al momento suddivide l’area sopra e intorno al supervulcano in due zone: la rossa e la gialla. La prima quella più esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici (ovvero valanghe di gas, cenere e frammenti vulcanici) è segmentata in quindici località: Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, alcune municipalità di Napoli (Posillipo, Bagnoli, Chiaia, Fuorigrotta, Vomero, Soccavo, Arenella, Chiaiano, Pianura), Marano di Napoli, Quarto, Giugliano in Campania. In quest’area l’evacuazione preventiva di tutta la popolazione (500mila persone) è l’unica misura da adottare per la salvaguardia delle vite, in caso di allarme. La zona gialla invece comprende i comuni di Villaricca, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Casavatore, parte di Marano di Napoli e altri ventiquattro quartieri del capoluogo campano. Questo territorio in caso di eruzione sarebbe esposto alla ricaduta delle ceneri vulcaniche. Qui potrebbero essere necessari degli allontanamenti temporanei di una parte dei residenti totali (800mila), soprattutto per quelli che abitano edifici eventualmente resi vulnerabili o poco accessibili dall’accumulo del materiale caduto.
Diversi sono anche i livelli di allerta -verde, giallo, arancione e rosso- che descrivono per i Campi Flegrei lo stato di attività del vulcano e scandiscono il tempo che precede una possibile ripresa dell’attività eruttiva. E’ prevista una fase di preallarme, in cui le persone che vogliono allontanarsi possono farlo ma solo autonomamente. Alla dichiarazione di “allarme” invece tutta la popolazione deve abbandonare la zona rossa e può scegliere di farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di tre giorni: le prime dodici ore saranno utili a permettere alle persone di prepararsi, le successive quarantotto riguardano la partenza della popolazione da tutti i Comuni interessati, le ultime dodici ore rappresentano infine un margine di sicurezza per la gestione di eventuali criticità.