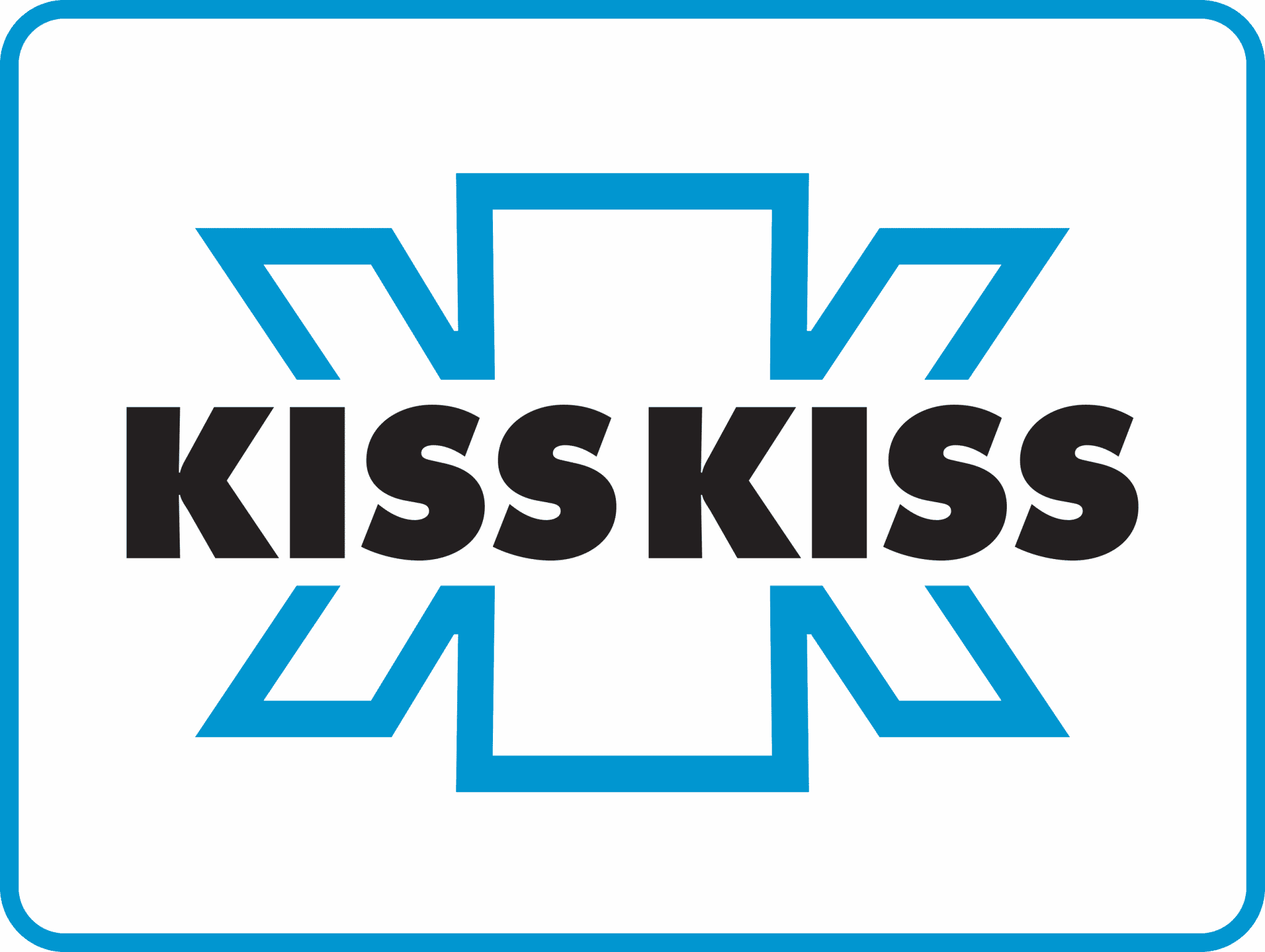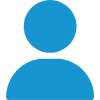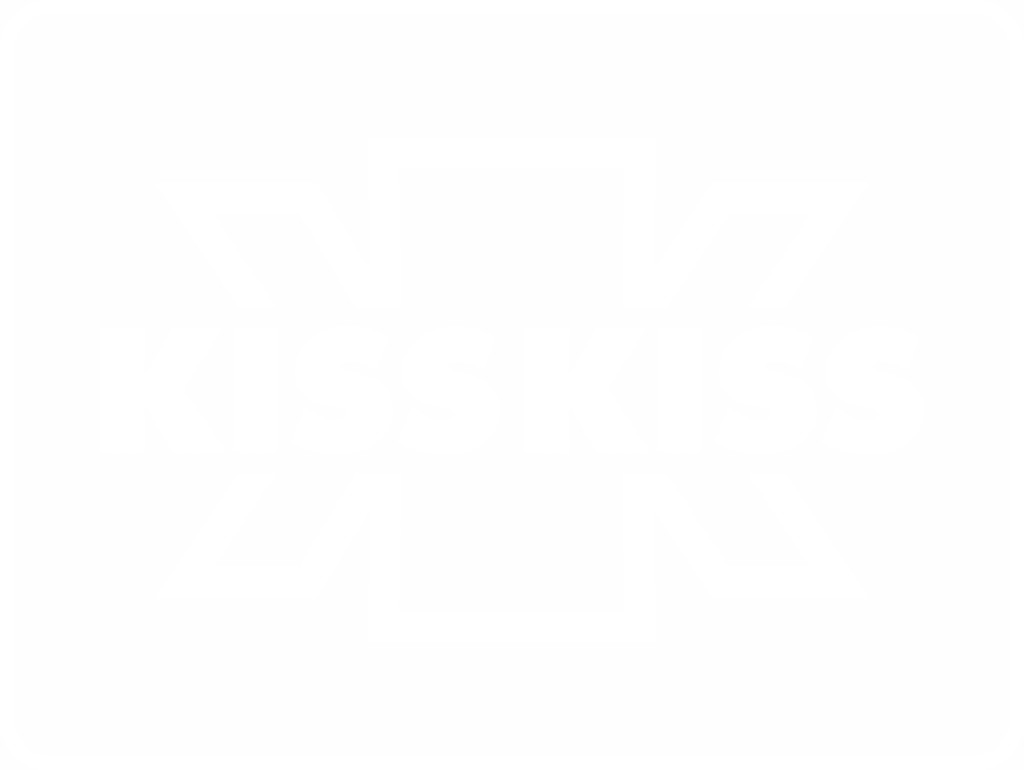Il pioniere della vignetta politica
Si è spento a 94 anni, a Milano, Giorgio Forattini, considerato il padre della satira politica italiana. Nato a Roma nel 1931, è stato il primo disegnatore a portare le vignette di commento politico sulle prime pagine dei quotidiani, trasformando un genere marginale in un linguaggio centrale del giornalismo.
Per oltre cinquant’anni le sue caricature hanno accompagnato e raccontato la vita politica del Paese, passando da Paese Sera e Panorama a La Repubblica, La Stampa, L’Espresso, QN e Il Giornale. Ironico, tagliente, spesso scomodo, Forattini ha saputo cogliere l’essenza dei protagonisti del potere, riducendoli a pochi tratti capaci di raccontare più di mille editoriali.
Dall’officina alla prima pagina
La sua non è stata una carriera lineare. Dopo gli studi classici e un breve periodo tra architettura e teatro, Forattini lavorò come operaio, rappresentante di commercio e illustratore pubblicitario. Negli anni Sessanta collaborò a campagne per la Fiat e l’Alitalia, prima di vincere, a quarant’anni, un concorso per disegnatori bandito da Paese Sera. Fu l’inizio di una rivoluzione.
Nel 1973 le sue vignette comparvero su Panorama, e l’anno seguente Paese Sera pubblicò la celebre illustrazione del referendum sul divorzio: una bottiglia di champagne con il tappo-Fanfani che vola in aria, simbolo della vittoria del “no”. Da quel momento la satira politica italiana non sarebbe più stata la stessa.
L’arte di dissacrare il potere
Forattini non risparmiava nessuno. Nelle sue caricature Craxi vestiva da fascista, D’Alema aveva i baffetti alla Hitler, Veltroni era un bruco, Prodi un monsignore bonario, Andreotti un vampiro ribattezzato “Andreacula”. I suoi disegni colpivano tutti, indipendentemente dal colore politico, e spesso finivano per scatenare polemiche e querele.
Negli anni Novanta, D’Alema lo citò per danni dopo la vignetta sul caso Mitrokhin, in cui il leader dei Democratici di sinistra veniva ritratto intento a “bianchettare” i nomi dei presunti agenti. Il processo non arrivò mai a sentenza, ma l’episodio rimase emblematico del rapporto conflittuale tra satira e potere. “Io disegno ciò che vedo – amava dire – non quello che conviene”.
Una libertà difesa con il sorriso
Politicamente si definiva “liberale”, ma più che alle ideologie, Forattini rispondeva alla propria indipendenza. Lavorò con Eugenio Scalfari a Repubblica dal 1976, alternando periodi di pausa e ritorni, poi con La Stampa e infine con Il Giornale. Nonostante le accuse di “fascismo” o “berlusconismo”, rivendicò sempre la libertà assoluta di satira: “Se una vignetta non piace, si può non pubblicarla, ma non si può impedirle di esistere”.
Negli ultimi anni aveva smesso di disegnare regolarmente, ma continuava a seguire con curiosità l’attualità. Lavorava da casa, fedele ai suoi rituali: l’ispirazione dal telegiornale delle 13, qualche schizzo nel pomeriggio e l’invio della vignetta la sera via fax. “La caricatura è un istinto – diceva – nasce senza premeditazione, come una risata improvvisa”.
Un’eredità incancellabile
Con Forattini scompare un testimone unico di mezzo secolo di storia italiana, un osservatore ironico che ha saputo raccontare i potenti con la spietata leggerezza di un sorriso. Le sue vignette non solo hanno fatto ridere, ma anche pensare, aprendo la strada a generazioni di disegnatori.
Nel suo segno inconfondibile resta la convinzione che la satira, per essere viva, debba sempre disturbare.