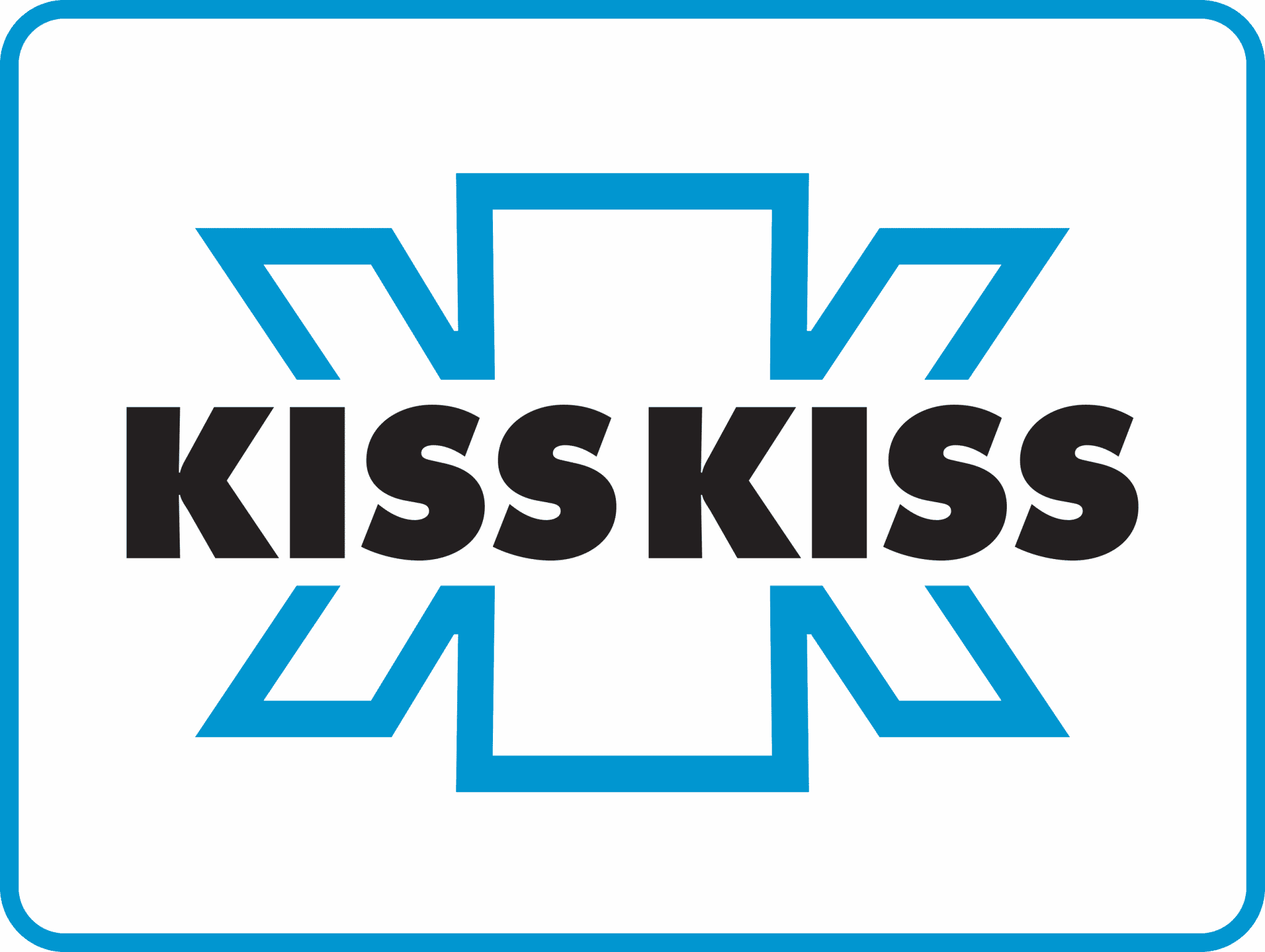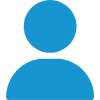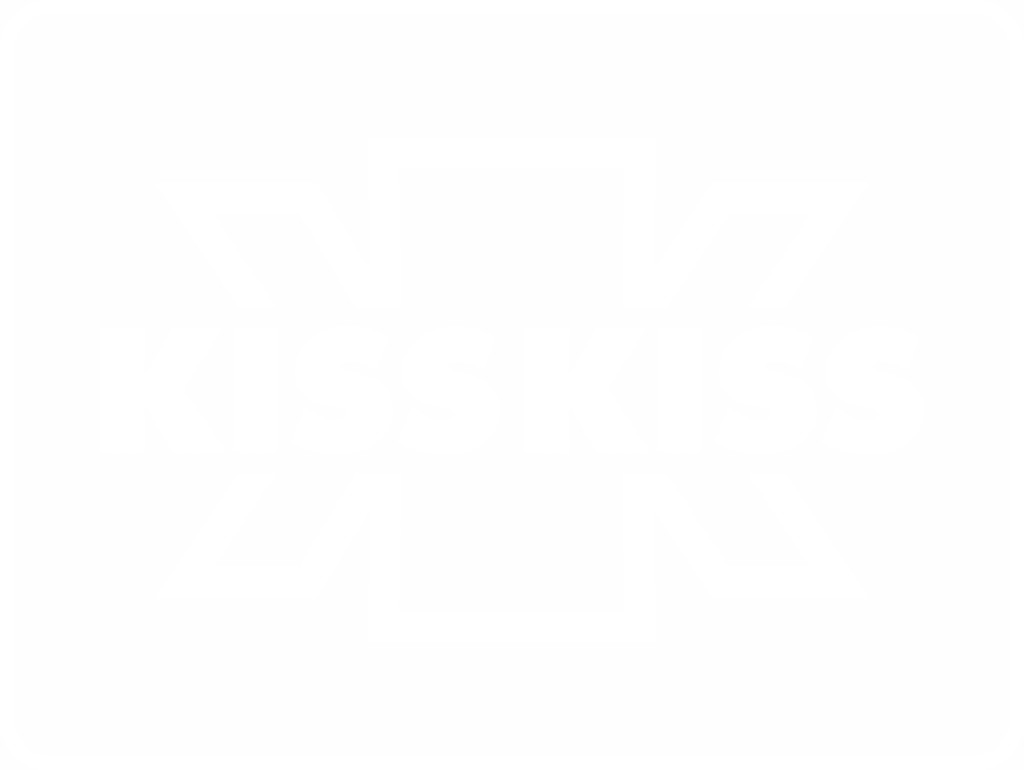«L’esofagite eosinofila è una malattia infiammatoria cronica e progressiva dell’esofago. In sostanza, il sistema immunitario del paziente riconosce come nocive alcune componenti della dieta, scatenando una reazione infiammatoria del tutto simile a quella delle malattie allergiche». Intervistata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la dottoressa Marcella Pesce, ricercatrice di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, spiega quali sono i meccanismi dell’esofagite eosinofila. «A causa di questa patologia – dice – si determina nell’esofago una risposta ad allergeni che sono tipicamente di natura alimentare. In questo modo si accumulano cellule di difesa del sistema immunitario – gli eosinofili, appunto – che irritano la parete e portano progressivamente l’esofago a irrigidirsi. Si può arrivare persino a un restringimento che rende impossibile la deglutizione». Di qui la difficoltà a ingoiare alcuni tipi di cibo, soprattutto se la consistenza è più fibrosa. Ma, va detto, i sintomi – soprattutto in una fase iniziale – possono essere misconosciuti e confusi con disordini più comuni, come la malattia da reflusso gastroesofageo. «Spesso – aggiunge la dottoressa Pesce – questo porta a una diagnosi tardiva. Basti pensare che, ad oggi, la latenza della diagnosi è superiore ai 5 anni, proprio perché i sintomi sono subdoli e intermittenti e possono variare anche in relazione all’età della persona colpita». Pesce spiega che la malattia ha un doppio picco di incidenza: uno in età pediatrica e l’altro, invece, in età giovane adulta. «Nei bambini, spesso, si notano difficoltà nell’alimentazione, con la comparsa di vomito, reflusso o rifiuto del cibo e, di conseguenza, si possono avere problemi di crescita. Negli adulti, invece, la sintomatologia più comune è la difficoltà a deglutire, con la sensazione che il boccone si blocchi a metà strada». Quando capita che il cibo resti bloccato nell’esofago, diventa indispensabile agire in fretta, con una gastroscopia d’urgenza. Esiste, tuttavia, la tendenza, in una fase iniziale, a sottovalutare o ignorare questi segnali. Inconsapevolmente, vengono messi in atto dei comportamenti compensativi. «Chi si riconosce nei sintomi di questa malattia – aggiunge la ricercatrice – dovrebbe considerare il campanello d’allarme e rivolgersi al medico, perché identificare tempestivamente la malattia consente di prevenire le complicanze a lungo termine. Se l’infiammazione continua indisturbata per anni, senza terapia, l’esofago può letteralmente irrigidirsi fino a restringersi, a causa delle cicatrici che si formano. La parete diventa meno elastica e quindi, nei casi più avanzati, può servire un intervento endoscopico».
Ma cosa sono i comportamenti adattivi? «Si tratta di modifiche spontanee che il paziente implementa per poter affrontare i sintomi. Spesso i pazienti stessi non sono consapevoli che il loro modo di mangiare è in qualche modo anomalo. Molti pazienti – ad esempio – evitano l’assunzione di compresse perché hanno fastidio, oppure tagliano il cibo in pezzi molto piccoli, masticano eccessivamente o bevono grandi quantità di acqua. Questi sono tutti esempi di strategie quotidiane che il paziente può implementare per attenuare e tamponare il disturbo, ma che rischiano di mascherare la malattia stessa. È fondamentale sensibilizzare non solo l’opinione pubblica, ma anche i medici di medicina generale, i pediatri di base, affinché siano in grado di riconoscere questi segnali e sospettare la malattia». Importante anche ribadire che spesso l’esofagite eosinofila è interconnessa ad altre manifestazioni allergiche. «Molti pazienti con esofagite eosinofila hanno anche asma, rinite, poliposi nasale o dermatite atopica. Facile comprendere perché la malattia richieda molto spesso un percorso diagnostico multidisciplinare e personalizzato, che può coinvolgere diverse figure professionali. Serve un approccio cucito su misura in relazione al tipo di manifestazione allergica. Il primo passo per la diagnosi è il medico di medicina generale o il pediatra di base: sta a loro sospettare la malattia sulla base dei comportamenti e dei sintomi. Poi, serve il parere di uno specialista: il gastroenterologo, visto che per poter ottenere la diagnosi serve necessariamente una gastroscopia con delle biopsie lungo le pareti dell’esofago. Ma un’altra figura chiave è l’allergologo, perché la maggior parte dei pazienti ha una storia di allergia e l’allergologo può eseguire un test cutaneo o sul sangue per identificare eventuali allergeni coinvolti. Inoltre, è fondamentale anche il nutrizionista per poter valutare eventuali deficit nutrizionali causati dalle esclusioni alimentari ed elaborare una dieta che sia nutrizionalmente bilanciata. In altri casi può essere necessario coinvolgere un otorinolaringoiatra se sono presenti sintomi di ostruzione nasale o perdita dell’olfatto, uno pneumologo se sono presenti sintomi respiratori e, in presenza di lesioni cutanee, il dermatologo. Sono malattie molto complesse, che spesso richiedono anche un supporto psicologico. In sostanza, la malattia è soltanto un tassello nell’ambito della complessità del quadro clinico che è il paziente, e pertanto è fondamentale affidarsi a centri specializzati per poter improntare un piano di diagnosi e cura personalizzato».